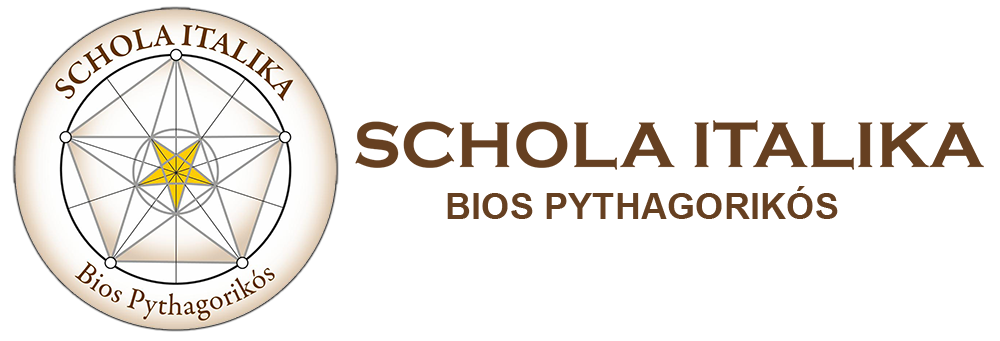Ritornanza, valori e significati
“Ritornanza”, “Restanza”, “Erranza” sono tre termini che presentano una certa compatibilità concettuale poiché racchiudono e condensano la suggestione del viaggio, dell’eterno cammino dell’uomo verso una meta fisica ovvero verso la consapevolezza di sé, offrendo spunti interessanti per indagare i significati socio-antropologici in quanto possono essere analizzati nei contesti identitari, culturali e sociali. La ritornanza e la restanza, in particolare, sono connesse ai temi dell’identità, della memoria e della comunità, rappresentando due facce della stessa medaglia nell’esperienza umana di luogo e appartenenza; concetti che ci invitano a riflettere sulle complessità del vivere in un mondo in continua evoluzione.
E’ stato un valente antropologo, il calabrese Vito Teti, il primo a parlare di una “antropologia della ritornanza”, dando vita così a una nuova branca della disciplina che sta conquistando sempre più l’interesse del mondo accademico, e non solo. Nei suoi studi Teti affronta, nello specifico, la fuga delle intelligenze, fenomeno spiccatamente marcato nel sud Italia, ma cita anche alcuni esempi virtuosi di giovani che sono tornati a casa investendo il proprio bagaglio formativo acquisito altrove a favore della loro terra. Sotto il profilo etimologico, il neologismo “ritornanza” coniato da Teti, di apparente sgrammaticatura, recupera una tendenza già inaugurata nei primi del Novecento dal filosofo francese Jacques Derrida, il quale utilizzò l’aggiunta del suffisso (-za) dei nomi di qualità al verbo restance (da résistance con eliminazione di –si-), nel significato di “resistenza psicoanalitica”. Di “restanza”, sia pure con diverse sfumature semantiche, parlò anche Giuseppe De Rita in tempi più recenti riferendosi a contesti più propriamente sociologici. In ambito socio-antropologico, se il termine restanza fa emergere il tema della resilienza e dell’impegno nella costruzione di comunità, il concetto di ritornanza suscita riflessioni sul valore delle origini e sul significato del ritorno, sia fisico che simbolico. Esplora come le memorie e le esperienze del passato possano influenzare l’identità presente di un individuo o di una comunità. Può rappresentare il ritorno a luoghi d’origine o a tradizioni culturali, un concetto spesso legato a esperienze di migranti che possono sentire un forte desiderio di riconnessione con le proprie radici. In questo senso la ritornanza può manifestarsi nel recupero di pratiche culturali, nell’adozione di cerimonie tradizionali o nel rinnovato interesse per la lingua e i costumi ancestrali.
L’archetipo del “ritorno” è comunque legato al nòstos, il viaggio di Ulisse narrato da Omero nell’Odissea. Un viaggio che, significativamente, è un ritorno: il suo obiettivo non è condurre l’eroe a una meta, ma ricondurlo in maniera circolare – sano e salvo e più esperto della vita – al suo originario punto di partenza, a casa. Una casa fisica, Itaca; una casa interiore, la conoscenza di sé. La circolarità del percorso connota il viaggio non come fine a sé tesso, ma come funzionale a un’acquisizione di esperienza e di conoscenza superiori; un progresso rilevabile e misurabile soltanto attraverso il confronto con il punto di partenza, cioè facendo ritorno al luogo nel quale l’individuo possa rispecchiare e conoscere la propria nuova identità. Tra i motivi letterari legati alla “ritornanza” si può annotare anche la parabola del figliol prodigo narrata nel Vangelo di Luca. Dopo una vita dissoluta, il giovane torna nella casa paterna con la consapevolezza del proprio decadimento, anche se non si aspetta di poter essere riconosciuto come un figlio; viene invece accolto dal padre con grande commozione a suggello della relazione profonda tra chi ha dato e ricevuto la vita.
In questo senso l’aforisma di Tolkien “non tutti coloro che vagano si perdono” è messo in discussione, ma il valore del ritorno supera il dissolvimento restituendo dignità all’erranza e, in definitiva, all’agire umano. Tale significato è rinvenibile anche nel brevissimo racconto di Franz Kafka – Il Ritorno, appunto – nel quale si ribadisce questa condizione di smarrimento: l’uomo contemporaneo è rappresentato come un viaggiatore il cui treno ha subito un incidente nel mezzo di un tunnel, del quale non si scorge più l’ingresso e solo per brevi tratti qualche bagliore fioco e sfuggente proveniente dall’uscita. E visto che questo sintetico contributo farà capolino in un giornale parrocchiale (pur se di rilevante spessore speculativo), mi sembra opportuno citare in conclusione Fëdor Dostoevskij. Nel grandioso romanzo I fratelli Karamazov lo scrittore russo mette in bocca al monaco Zosima le parole della sua fede: “In verità, sulla terra noi vaghiamo un po’ a caso e se non avessimo davanti agli occhi la preziosa immagine di Cristo, ci smarriremmo e ci perderemmo del tutto, come il genere umano prima del diluvio”.
di Gianfranco Bonanno (dal mensile di cultura Botros n.27 – 10 Agosto 2024)